~ Giuseppe D’Orsi ~ La lotta ai culti pagani tra i longobardi al tempo di Liutprando”
La legislazione longobarda non si esaurisce all’Editto di Rotari, ma i sovrani longobardi successivi emendano, chiariscono e aggiungono nuove norme all’editto. Tra questi, l’intervento più corposo è apportato dal re Liutprando, il cui obiettivo è quello di integrare i sempre più forti valori cristiani del popolo longobardo all’interno delle fonti normative. Tale intento è chiaro sin dal preambolo “Io, Liutprando, in nome di Dio, eccellentissimo cristiano re dei Longobardi”, nonché in moltissime delle nuove norme emanate, a partire dalla possibilità di donare parte del proprio patrimonio a monasteri per salvare la propria anima (donatio pro anima), passando per le nuove regole riguardo al matrimonio modellate sul diritto canonico, per arrivare al diritto di asilo in chiesa e alla possibilità di affrancare uno schiavo in chiesa (manumissio in ecclesia). Se è vero che tali norme, da un lato, lungi dall’essere innovative, si limitano probabilmente a recepire istituti e prassi già radicate in una società ormai mutata e improntata fortemente al cristianesimo; dall’altro lato tuttavia si pongono anche come obiettivo quello di estirpare ogni residua traccia di superstizioni e culti ancestrali ancora evidentemente forti tra i longobardi. Infatti, i capitoli emanati da Liutprando sono la più chiara testimonianza che ancora nell’VIII secolo tra i cattolicissimi longobardi (o tra i contadinotti residenti nel regno che comunque si ormai autodefinivano longobardi), residuassero forti elementi di paganesimo. Non è chiaro se tali credenze per una parte della popolazione fossero esclusive o più probabilmente andassero a colorare un cristianesimo non puro; ad ogni modo la legislazione di Liutprando vanta il primato di essere l’unica codificazione germanico-barbarica altomedievale a prefissarsi il chiaro obiettivo di eliminare ogni residuo delle tradizioni e delle pratiche correlate a culti pagani. Vediamo insieme in che modo!
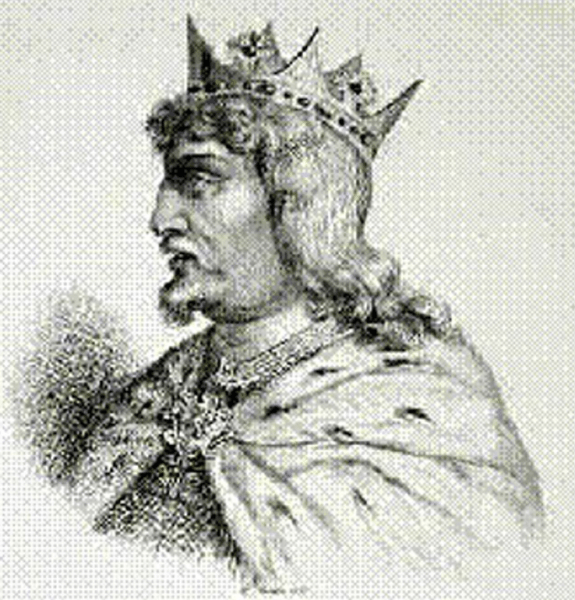
La condanna degli indovini e chi ne fa uso
Le norme che particolarmente ci interessano sono i capitoli 84 e 85 della legislazione del quindicesimo anno di Liutprando che richiamano esplicitamente in diritto canonico che si era già occupato di simili questioni. Tali norme si scagliano e condannano alcune pratiche associate a culti pagani o che comunque si pongono in contrasto con la religione cristiana. L’indice è puntato in primis contro gli indovini e chi di essi ne fa uso per ottenere vaticini o responsi di qualsiasi genere. Dalla complessità e dal dettaglio con cui le norme sono scritte se ne può derivare che questa era una pratica (che fosse di origine tribale o più probabilmente di origine precristiana tra la popolazione romana) tutt’altro che isolata ancora nell’VIII secolo.
Dunque, al fine di dissuadere tale costume, Liutprando prevede una pena altissima per chi si fosse recato da un indovino, pari a metà del proprio guadrigildo (valore predeterminato dal legislatore a mo’ di risarcimento per la composizione della lite nel caso in cui un soggetto fosse stato ucciso), da pagare al re stesso.
Liutprando si premura di evitare possibili elusioni della legge: se fosse stato uno schiavo a recarsi da un indovino, sarà condannato il suo padrone, salvo che quest’ultimo riesca a dimostrare che lo schiavo si sia recato dall’indovino di propria iniziativa e senza il suo consenso; in tal caso per evitare il pagamento della sanzione al re, avrà l’obbligo di vendere lo schiavo fuori dalla provincia. E l’indovino, invece, che fine fa? Liutprando regola minuziosamente gli obblighi in capo a giudici, sculdasci, saltari e decani (ufficiali del regno maggiori e minori) nel caso abbiano notizia dell’esistenza di indovini e applica loro il metodo del bastone e della carota: da un lato li condanna ad importanti pene pecuniarie in caso di negligenza nell’arrestare gli indovini (metà del proprio guadrigildo) o in caso di assoluzione degli stessi che sia per pietà o per corruzione (intero proprio guadrigildo); dall’altro lato autorizza tali ufficiali del regno a vendere tali indovini fuori provincia come schiavi e a tenere per sé il ricavato. Da qui deduciamo che la pena alla quale soggiace l’indovino è una delle più pesanti dell’intero Editto dopo la pena di morte, ovvero la trasformazione del reo in schiavo (se non fosse già schiavo di per sé).

La condanna del culto degli alberi e la storia di S. Barbato
Oltre agli indovini, le norme sopra citate, applicando la solita pena di metà del guadrigildo, condannano un’altra pratica, questa volta di origine germanica (ma diffusa anche in altre parti del mondo): il culto degli alberi e delle fonti d’acqua. Tale culto, già attestato da Tacito nel suo De Germania, esaltava e mitizzava boschi e foreste come grandi spazi sacri nei quali venivano celebrati riti religiosi, proprio come i templi. Alcuni alberi colossali assumevano particolarmente la funzione di colonna-idolo alla quale le pratiche religiose si rivolgevano direttamente.
Ma quanto in una società longobarda fortemente cristianizzata dell’VIII secolo perdurava ancora l’ancestrale culto degli alberi (in gergo detto “dendrolatria”)? Non è possibile indicare con chiarezza la portata di tale culto per la scarsezza di documentazione. Nell’agiografia “Vita Barbati e Piscopi Beneventani”, tra storia e leggenda si mettono per iscritto alcune pratiche longobarde ancora attive a fine VII secolo. Per la precisione siamo nel periodo in cui Grimoaldo regnava sui Longobardi (dal 662 al 671) e suo figlio Romualdo governava su Benevento e, allo stesso tempo, Costante II imperatore romano di Costantinopoli tentava la riconquista nel sud Italia. Costante II dopo un susseguirsi di trionfi si avvicinava ad assediare Benevento. A quel punto un sacerdote di nome Barbato, poi diventato vescovo di Benevento e in seguito santo, si sarebbe scagliato pubblicamente contro le idolatrie ancora imperversanti nel ducato, affibbiando ad esse la colpa delle sciagure che stavano accadendo (topos ricorrente in tutta l’età antica e medievale) e provando a convincere i beneventani a convertirsi. Avrebbe puntato l’indice soprattutto contro alcuni riti pagani che coinvolgevano un grande albero sacro fuori dalla città al quale era appesa una vipera di bronzo (animale che rimanda sia ai culti longobardi, sia al culto di Iside ben sviluppato a Benevento). In specifiche ricorrenze i partecipanti ai riti pagani, adorando quell’albero vi avrebbero sospeso una pelle di animale e durante corse sfrenate a cavallo avrebbero cercato di afferrare un pezzo della pelle, che poi avrebbero sbranato in un rito considerato empio (rituale totemico in cui i partecipanti divoravano il corpo teriomorfo del dio). San Barbato sarebbe riuscito a convincere Romualdo stesso a promettere a Dio che se il popolo longobardo si fosse salvato, avrebbe estirpato tale culto. Intanto, Costante II, dopo l’arrivo in aiuto di Benevento di Grimoaldo dalla Lombardia Maior, patì alcune sconfitte e decise di ritirarsi in Sicilia e lasciare l’assedio. A quel punto Romualdo, mantenendo la promessa fatta a San Barbato, avrebbe condannato quel culto e fatto abbattere quel grande albero.
Indipendentemente dalla veridicità dei dettagli della storia, che comunque potrebbero essere verosimili, è interessante constatare come alla fine del VII secolo sicuramente elementi pagani erano ancora presenti tra i longobardi (o comunque tra la popolazione romana ormai “longobardizzata”).

Per chi fosse interessato, la storia dell’albero di Benevento non finisce lì. Infatti, Pietro Pieperno un medico beneventano vissuto nel XVII secolo, nel suo trattato “De nuce maga” (“Della Superstiziosa Noce di Benevento”) ci racconta che quell’albero demoniaco sarebbe risorto ad opera del demonio e che esso doveva essere identificato proprio con il noce presso il quale secoli dopo le streghe (a Benevento dette Janare) si riunivano per la loro iniziazione col diavolo e poi regolarmente per ballarci attorno! Il rito di iniziazione delle streghe presso il noce di Benevento fu effettivamente riportato nei verbali degli interrogatori delle presunte streghe davanti agli Inquisitori di mezza Europa (ad esempio Matteuccia da Todi) e influì molto nella cultura popolare italiana dei secoli successivi (fu riportato sulla locandina della composizione Le Streghe di Niccolò Paganini, a sua volta tratto dal balletto Il noce di Benevento di Franz Xaver Süssmayr) . Ma questa è un’altra storia e ve la racconteremo a tempo debito!

